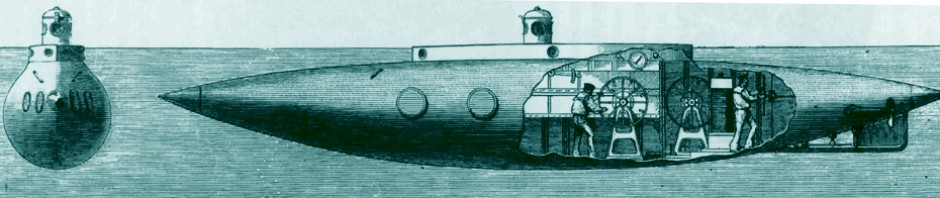«Un, due, tre… liberi tutti!» (formula rituale di un gioco, il «nascondino»)
Il proposito di abolire il carcere, nonché ogni forma di prigionia, è senza dubbio saggio, nobile, ammirevole e, soprattutto, radicalmente umano. Personalmente, posso e voglio definirmi un abolizionista e senza ombra di dubbio. Purtroppo, però, quando ci si addentra nella questione nei suoi aspetti teorici e, com’è necessario, in quelli pratici e propositivi, ci si accorge di aver messo la mano in un nido di vipere, tutte altrettanto seppure diversamente mordaci, o, se proprio va bene, di avere di fronte un gioco di scatole cinesi. Un problema rimanda a un altro, un’ipotetica soluzione ne azzanna un’altra, tuttavia non meno ipotetica, e via andando. Non è un caso che: 1) le ipotesi abolizioniste (del carcere) siano state a lungo estranee alla teoria, spesso scaduta in ideologia, che si è pretesa rivoluzionaria; per limitarci all’Italia, la frazione sedicente rivoluzionaria, comunista o anarchica che si definisse, ha sempre preferito aggirare la questione attraverso formule tutto sommato sloganistiche (dall’immondo «Fuori i compagni dalle galere, dentro i padroni e le camicie nere», che riproponeva, anzi esaltava, la natura della segregazione carceraria, limitandosi a cambiarne il segno meramente politico, al più generoso «Da San Vittore all’Ucciardone, un solo grido: evasione», mentre sappiamo che di evasioni ce ne sono state assai poche e in congiunture particolari e che comunque non poteva essere, questa, una soluzione che aspirasse alla necessaria generalità, passando attraverso al «… tutte le carceri salteranno in aria», quando, in verità, le poche – in costruzione – che sono saltate parzialmente in aria sono state tutte condotte a termine, con enormi vantaggi per gli appaltatori e nessuno per i detenuti); 2) all’interno del movimento abolizionista, pur assai esiguo e in specie in Italia, ci siano delle differenze di sostanza che coprono quasi l’intero arco delle opinioni: da chi ritrova disutile il carcere per le nostre società (magari parzialmente e dunque deputandolo solo come luogo di contenimento dello «zoccolo duro» della devianza, comune o politica che sia) a chi lo riprova per ragioni essenzialmente etiche, umanitarie, da chi propone e si propone soluzioni «alternative» maggiormente compatibili con le culture e le società moderne, a chi esalta, diremmo stirnerianamente, solo l’individuo (anzi, bisognerebbe scrivere l’Individuo) sottolineandone l’u/Unicità e, dunque, abolendo società e comunità – almeno nei concetti, visto che in pratica è ben altro affare; 3) le ipotesi abolizioniste, e i movimenti che ne sono conseguiti, siano state per lo più – tranne casi eccezionali – avanzate da «esperti», «specialisti» del settore; il che, è ovvio, non le squalifica di per sé, ma ci dà in certo modo la temperatura della discussione: come quasi sempre avviene per la malattia, di essa si occupano soprattutto i malati medesimi e chi se ne interessa «professionalmente» o «scientificamente»; acutamente T.W. Adorno notava, in Minima moralia, come i malati non sappiano parlar d’altro che delle loro malattie; possiamo aggiungere che i professionisti non sanno parlar d’altro che delle loro professioni. Tutto ciò detto per amor di verità, bisogna comunque tentare di cacciare la mano in questo nido di vipere o, se si preferisce, dissacrare l’apparente magia delle scatole cinesi. La prima questione che si pone è la seguente: è possibile, oppure no, abolire il carcere? Immediatamente ne segue una sorta di schieramento. Per un «radicale», se è possibile, allora significa che questa abolizione è nell’interesse della società presente, che peraltro egli vuole combattere, cambiare o distruggere, e dunque non val troppo la pena di occuparsene; lo faranno comunque altri e, in ogni caso, questa «abolizione» sarebbe soltanto spettacolare, mentre verrebbero rinnovate e rimodernate le forme di controllo sociale e perciò di prigionia in senso ampio. Per un «riformista», se è veramente impossibile, è piuttosto utile mettere mano a delle modificazioni che, da un lato, lascino fuori dal carcere quanti più possibili e, dall’altro, «ammorbidiscano» le condizioni di quanti dentro ci restano.  Il «radicale» rischia di disinteressarsene, se non attraverso vaghe e fumose dichiarazioni di principio, affaccendandosi, nel frattempo, in altre faccende e lasciando mano libera ai professionisti del «problema», aspettando un momento catartico x o y o z, in cui tutto si risolverà e che, onestamente, pare del tutto improbabile, almeno sotto questa formulazione. Il «riformista», quale che sia la sua indole e natura, rischia di contribuire alla perpetuazione ad aeternum di carceri, leggi ecc., attraverso il loro addolcimento, la loro modernizzazione, e soprattutto di accettare quella che per molti versi sembra essere una tendenza sociale: da un lato, le «misure alternative», per chi ha commesso reati lievi o è stato condannato a pene spropositate (com’è stato in Italia nel periodo della cosiddetta emergenza, che peraltro si rinnova costantemente, con sempre nuovi soggetti/oggetti) e ha già scontato una parte sufficiente (?) della pena o per chi si è ravveduto e corretto o, infine, per quelli che non sono ritenuti socialmente pericolosi (l’omicida della moglie/marito ha incommensurabilmente più possibilità di ottenere dei «benefici» che non il rapinatore/trice; va da sé non è che uno si sposi tutti i giorni e pochi giorni dopo si liquidi il coniuge, mentre il rapinatore può averci preso gusto, aver constatato che in cinque minuti poteva passare da una condizione di miseria a una di relativa abbondanza e, dunque, essersi preso il vizietto); dall’altro lato, il «bagno penale» per chi, per una qualche ragione, viene considerato irrecuperabile, a cui, sostanzialmente, viene applicata una pena di morte differita; non paia strano questo concetto di bagno penale, di Cayenna moderna, perché questo già avviene, nelle carceri speciali di tutti i paesi (non soltanto nell’Italia convulsa e percorsa da molti fremiti sociali, ma altrettanto nell’ordinata e tranquilla Svezia) e soprattutto perché questo, e da anni, è stato paventato da lucidi «democratici sinceri» (a ciascuno il suo) che, proprio per essere rotelle dell’ingranaggio, si sono resi conto di dove la macchina tende ad andare; non deliri estremistici, quindi, né paranoie di detenuti in vena di protagonismo, ma franche osservazioni di «operatori» non del tutto ottenebrati dal mestiere. Come sempre, tra due errori non se ne può scegliere uno e privilegiarlo, benché, per quanto a me attiene, veda con occhio assai più sospettoso, data la mia indole selvatica, l’attività del preteso riformatore che non la passività del sedicente radicale. Ma senza troppe ciance, è realistico o irrealistico ipotizzare l’abolizione delle carceri?
Il «radicale» rischia di disinteressarsene, se non attraverso vaghe e fumose dichiarazioni di principio, affaccendandosi, nel frattempo, in altre faccende e lasciando mano libera ai professionisti del «problema», aspettando un momento catartico x o y o z, in cui tutto si risolverà e che, onestamente, pare del tutto improbabile, almeno sotto questa formulazione. Il «riformista», quale che sia la sua indole e natura, rischia di contribuire alla perpetuazione ad aeternum di carceri, leggi ecc., attraverso il loro addolcimento, la loro modernizzazione, e soprattutto di accettare quella che per molti versi sembra essere una tendenza sociale: da un lato, le «misure alternative», per chi ha commesso reati lievi o è stato condannato a pene spropositate (com’è stato in Italia nel periodo della cosiddetta emergenza, che peraltro si rinnova costantemente, con sempre nuovi soggetti/oggetti) e ha già scontato una parte sufficiente (?) della pena o per chi si è ravveduto e corretto o, infine, per quelli che non sono ritenuti socialmente pericolosi (l’omicida della moglie/marito ha incommensurabilmente più possibilità di ottenere dei «benefici» che non il rapinatore/trice; va da sé non è che uno si sposi tutti i giorni e pochi giorni dopo si liquidi il coniuge, mentre il rapinatore può averci preso gusto, aver constatato che in cinque minuti poteva passare da una condizione di miseria a una di relativa abbondanza e, dunque, essersi preso il vizietto); dall’altro lato, il «bagno penale» per chi, per una qualche ragione, viene considerato irrecuperabile, a cui, sostanzialmente, viene applicata una pena di morte differita; non paia strano questo concetto di bagno penale, di Cayenna moderna, perché questo già avviene, nelle carceri speciali di tutti i paesi (non soltanto nell’Italia convulsa e percorsa da molti fremiti sociali, ma altrettanto nell’ordinata e tranquilla Svezia) e soprattutto perché questo, e da anni, è stato paventato da lucidi «democratici sinceri» (a ciascuno il suo) che, proprio per essere rotelle dell’ingranaggio, si sono resi conto di dove la macchina tende ad andare; non deliri estremistici, quindi, né paranoie di detenuti in vena di protagonismo, ma franche osservazioni di «operatori» non del tutto ottenebrati dal mestiere. Come sempre, tra due errori non se ne può scegliere uno e privilegiarlo, benché, per quanto a me attiene, veda con occhio assai più sospettoso, data la mia indole selvatica, l’attività del preteso riformatore che non la passività del sedicente radicale. Ma senza troppe ciance, è realistico o irrealistico ipotizzare l’abolizione delle carceri? Per il momento, lasciamo la domanda in sospeso, affermando però che è un gran bene che si cominci a interrogarsi su questa possibilità (e, d’altronde, il comunismo è possibile, fuori e contro gli squallidi esempi del cosiddetto socialismo reale? E l’anarchia, al di là delle chiacchiere,e a dispetto di esse, di coloro che si chiamano anarchici? E l’acrazia, di cui i più non conoscono neppure il significato terminologico?). Non solo. È essenziale che si formi una cultura – nemica di tutte le culture stereotipe – che ponga come uno dei suoi centri, dei suoi «soli», il progetto dell’abolizione di ogni carcere. Di corsa, quasi trafelato, arriva il secondo problema: è possibile l’abolizione del carcere senza il parallelo e contemporaneo disuso delle leggi, dei codici, delle sanzioni? È evidente che è il carcere a spiegare i codici e non viceversa. Salta agli occhi che un corpus giuridico che non avesse alcuna applicazione pratica, sarebbe un mero esercizio ideologico o letterario. L’articolo di legge vale perché presuppone una pena, e la pena vale perché vi sono delle concrete forme di sua attuazione. Al ladro si può mozzare la mano o lo si può incarcerare per un certo tempo, ma, in qualsiasi società, non si può affermare che il ladrocinio è reato ed è immorale e non prescrivere alcuna sanzione per chi, alla faccia dei consigli morali, lo compia allegramente e, per giunta e disgrazia, si faccia acchiappare. Il carcere è sicuramente un fenomeno storicamente determinato e, dunque, in quanto tale, soggiace alle leggi della storia: può anche scomparire, ma non può eclissarsi la sanzione – non il suo mero concetto, bensì la sua concreta pratica – e, pertanto, senza dubbio siamo obbligati ad affrontare la grande questione: che senso ha qualsiasi legge che autorizzi o vieti checchessia? Un pensiero abolizionista coerente non può limitarsi a preconizzare l’abolizione di ogni carcere «formale» (diremmo murario) ma deve proporsi anche la soppressione di quelle forme di carcere immateriale, diffuso, che comunque rimandano alla prigionia e al controllo sociale; affinché ciò sia realistico, vanno dismessi il concetto di sanzione penale e soprattutto la sua materializzazione pratica. L’abolizione di ogni codice penale sembra, quindi, essere nel contempo la premessa e la conclusione di un’ipotesi abolizionista del carcere. Ma tutto ciò è realmente proponibile, vale a dire ci si può «seriamente» lavorare sopra? Voglio dire: al di là dei vagheggiamenti collettivi o soggettivi, il cui massimo esempio resta tuttora l’appello di Sade, «Francesi, ancora uno sforzo…», contenuto in La philosophie dans le boudoir, che rimane un testo effettivamente scandaloso non per i multipli e molteplici accoppiamenti sessuali e orgiastici, quanto piuttosto per questa invettiva e per la filosofia che vi è sottesa. In altre parole, oltre le utopie, di cui «abbiamo bisogno» ma che del pari risultano «ripugnanti» perché smascherano il totalitarista che è in noi, per la ragione semplice e sufficiente in sé che, quale che sia il sistema di governo che regge l’utopia in questione, esso è sempre presieduto da un dittatore assoluto: l’«autore», come scrive pregnantemente T.M. Disch, nella società storicamente determinata – l’attuale, compresi i suoi potenziali sviluppi – ha senso l’ipotesi di abolire non solo le carceri, ma ogni forma di prigionia, non solo tutte le prigionie ma le sanzioni penali che le determinano, non solo le sanzioni penali ma le leggi da cui necessariamente discendono?
Per il momento, lasciamo la domanda in sospeso, affermando però che è un gran bene che si cominci a interrogarsi su questa possibilità (e, d’altronde, il comunismo è possibile, fuori e contro gli squallidi esempi del cosiddetto socialismo reale? E l’anarchia, al di là delle chiacchiere,e a dispetto di esse, di coloro che si chiamano anarchici? E l’acrazia, di cui i più non conoscono neppure il significato terminologico?). Non solo. È essenziale che si formi una cultura – nemica di tutte le culture stereotipe – che ponga come uno dei suoi centri, dei suoi «soli», il progetto dell’abolizione di ogni carcere. Di corsa, quasi trafelato, arriva il secondo problema: è possibile l’abolizione del carcere senza il parallelo e contemporaneo disuso delle leggi, dei codici, delle sanzioni? È evidente che è il carcere a spiegare i codici e non viceversa. Salta agli occhi che un corpus giuridico che non avesse alcuna applicazione pratica, sarebbe un mero esercizio ideologico o letterario. L’articolo di legge vale perché presuppone una pena, e la pena vale perché vi sono delle concrete forme di sua attuazione. Al ladro si può mozzare la mano o lo si può incarcerare per un certo tempo, ma, in qualsiasi società, non si può affermare che il ladrocinio è reato ed è immorale e non prescrivere alcuna sanzione per chi, alla faccia dei consigli morali, lo compia allegramente e, per giunta e disgrazia, si faccia acchiappare. Il carcere è sicuramente un fenomeno storicamente determinato e, dunque, in quanto tale, soggiace alle leggi della storia: può anche scomparire, ma non può eclissarsi la sanzione – non il suo mero concetto, bensì la sua concreta pratica – e, pertanto, senza dubbio siamo obbligati ad affrontare la grande questione: che senso ha qualsiasi legge che autorizzi o vieti checchessia? Un pensiero abolizionista coerente non può limitarsi a preconizzare l’abolizione di ogni carcere «formale» (diremmo murario) ma deve proporsi anche la soppressione di quelle forme di carcere immateriale, diffuso, che comunque rimandano alla prigionia e al controllo sociale; affinché ciò sia realistico, vanno dismessi il concetto di sanzione penale e soprattutto la sua materializzazione pratica. L’abolizione di ogni codice penale sembra, quindi, essere nel contempo la premessa e la conclusione di un’ipotesi abolizionista del carcere. Ma tutto ciò è realmente proponibile, vale a dire ci si può «seriamente» lavorare sopra? Voglio dire: al di là dei vagheggiamenti collettivi o soggettivi, il cui massimo esempio resta tuttora l’appello di Sade, «Francesi, ancora uno sforzo…», contenuto in La philosophie dans le boudoir, che rimane un testo effettivamente scandaloso non per i multipli e molteplici accoppiamenti sessuali e orgiastici, quanto piuttosto per questa invettiva e per la filosofia che vi è sottesa. In altre parole, oltre le utopie, di cui «abbiamo bisogno» ma che del pari risultano «ripugnanti» perché smascherano il totalitarista che è in noi, per la ragione semplice e sufficiente in sé che, quale che sia il sistema di governo che regge l’utopia in questione, esso è sempre presieduto da un dittatore assoluto: l’«autore», come scrive pregnantemente T.M. Disch, nella società storicamente determinata – l’attuale, compresi i suoi potenziali sviluppi – ha senso l’ipotesi di abolire non solo le carceri, ma ogni forma di prigionia, non solo tutte le prigionie ma le sanzioni penali che le determinano, non solo le sanzioni penali ma le leggi da cui necessariamente discendono? La risposta non è affatto scontata. Infatti si può tranquillamente asserire che no, non è molto probabile e forse nemmanco possibile. Ma, con altrettanta tranquillità, si può sostenere che sarebbe necessario. E, ciò che è necessario, quando assume la coscienza della sua necessità, diventa possibile, addirittura probabile. Ma una simile questione ci porta ancora più lontano. E, come sempre, si creano gli schieramenti. Da quello gradualista («iniziamo a eliminare gli effetti più nefasti di questo sistema») a quello estremista («non si possono modificare degliaspetti di questa società senza rovesciarla completamente»), da quello «neoilluminista» («è necessario che la società nel suo complesso si renda conto del disastro mentale, sociale ed ecologico a cui va incontro, e si fornisca degli antidoti») a quello «ipersoggettivista», che sussume neoleninismi, neobakuninismi e neostirnerismi secondo queste varianti: «va imposta la ragione della Storia, da parte di alcuni organizzati in nome di tutti»; «è solo la collettività che può decidere, ma essa va indirizzata da chi si è reso conto delle esigenze generali»; «è solo l’individuo che deve prendere coscienza dellasua singolarità e, con ciò stesso, non sottomettersi più ad alcun ordinamento costituito, comunque alienante». A mio personale avviso, c’è del vero e del falso, sia pure in mescolanze diverse, in tutte queste proposizioni. Ma nessuna mi soddisfa. Così, se è evidente che solo una trasformazione radicale della società può consentire una trasformazione radicale del Diritto, non è altrettanto evidente quale sia la società realmente umana a cui aspirare né quale Diritto essa debba concepire e assumere, e neppure che una società, storicamente intesa, sia necessaria e, quindi, che sia necessario un Diritto. D’altronde è assai arduo, anche teoreticamente, ipotizzare una società che sia del pari una a-società, una comunità, quale che sia, che non si dia delle leggi o delle regole per la convivenza dei molti e che, dunque, non presupponga, almeno concettualmente, dei trasgressori, ed è assolutamente ridicolo costruire un castello ideologico fondato su idee del tutto improbabili come quello della «bontà intrinseca dell’uomo» (quando sappiamo che ogni uomo è il precipitato di determinate composizioni sociali) o della «forza della Natura e della sua capacità di autoregolamentarsi», quando, se vogliamo essere onesti, manco sappiamo più cosa voglia dire natura, al di là delle elegie nostalgiche, però assai moderne e amministrative, tinte di verdognolo. Credo chequesta società vada scossa dalle sue fondamenta – economiche, sociali, ambientali, mentali, strutturali – e che questa trasformazione radicale la si possa metaforizzare come non il rovesciamento di un guanto (comunque protezione da qualcosa, seppure con il segno rovesciato). Credo, peraltro, che un’associazione societaria, come si è storicamente determinata, non sia inevitabile, mentre è impossibile prescindere, anche in via ipotetica, da comunità umane, di soggetti, in qualche modo in rapporto tra di loro o «federate». Credo, infine, che queste comunità possano fare ameno di leggi nella misura in cui esprimono una effettiva dialettica tra le diversità. Ma tutto questo è di là da venire e la vecchia talpa sembra stanca di scavare. Eppure il carcere materialmente esiste. Ed è un problema non dappoco per chi vi è rinchiuso, per chi si guadagna il salario della vergogna amministrandolo, per chi lo teme e anche soltanto per ogni persona sensata, umana e di buon gusto.
La risposta non è affatto scontata. Infatti si può tranquillamente asserire che no, non è molto probabile e forse nemmanco possibile. Ma, con altrettanta tranquillità, si può sostenere che sarebbe necessario. E, ciò che è necessario, quando assume la coscienza della sua necessità, diventa possibile, addirittura probabile. Ma una simile questione ci porta ancora più lontano. E, come sempre, si creano gli schieramenti. Da quello gradualista («iniziamo a eliminare gli effetti più nefasti di questo sistema») a quello estremista («non si possono modificare degliaspetti di questa società senza rovesciarla completamente»), da quello «neoilluminista» («è necessario che la società nel suo complesso si renda conto del disastro mentale, sociale ed ecologico a cui va incontro, e si fornisca degli antidoti») a quello «ipersoggettivista», che sussume neoleninismi, neobakuninismi e neostirnerismi secondo queste varianti: «va imposta la ragione della Storia, da parte di alcuni organizzati in nome di tutti»; «è solo la collettività che può decidere, ma essa va indirizzata da chi si è reso conto delle esigenze generali»; «è solo l’individuo che deve prendere coscienza dellasua singolarità e, con ciò stesso, non sottomettersi più ad alcun ordinamento costituito, comunque alienante». A mio personale avviso, c’è del vero e del falso, sia pure in mescolanze diverse, in tutte queste proposizioni. Ma nessuna mi soddisfa. Così, se è evidente che solo una trasformazione radicale della società può consentire una trasformazione radicale del Diritto, non è altrettanto evidente quale sia la società realmente umana a cui aspirare né quale Diritto essa debba concepire e assumere, e neppure che una società, storicamente intesa, sia necessaria e, quindi, che sia necessario un Diritto. D’altronde è assai arduo, anche teoreticamente, ipotizzare una società che sia del pari una a-società, una comunità, quale che sia, che non si dia delle leggi o delle regole per la convivenza dei molti e che, dunque, non presupponga, almeno concettualmente, dei trasgressori, ed è assolutamente ridicolo costruire un castello ideologico fondato su idee del tutto improbabili come quello della «bontà intrinseca dell’uomo» (quando sappiamo che ogni uomo è il precipitato di determinate composizioni sociali) o della «forza della Natura e della sua capacità di autoregolamentarsi», quando, se vogliamo essere onesti, manco sappiamo più cosa voglia dire natura, al di là delle elegie nostalgiche, però assai moderne e amministrative, tinte di verdognolo. Credo chequesta società vada scossa dalle sue fondamenta – economiche, sociali, ambientali, mentali, strutturali – e che questa trasformazione radicale la si possa metaforizzare come non il rovesciamento di un guanto (comunque protezione da qualcosa, seppure con il segno rovesciato). Credo, peraltro, che un’associazione societaria, come si è storicamente determinata, non sia inevitabile, mentre è impossibile prescindere, anche in via ipotetica, da comunità umane, di soggetti, in qualche modo in rapporto tra di loro o «federate». Credo, infine, che queste comunità possano fare ameno di leggi nella misura in cui esprimono una effettiva dialettica tra le diversità. Ma tutto questo è di là da venire e la vecchia talpa sembra stanca di scavare. Eppure il carcere materialmente esiste. Ed è un problema non dappoco per chi vi è rinchiuso, per chi si guadagna il salario della vergogna amministrandolo, per chi lo teme e anche soltanto per ogni persona sensata, umana e di buon gusto. Perciò si ha da intervenire concretamente, ciascuno secondo le sue conoscenze e possibilità. In quanto a me, so per esperienza diretta e certa che un carcere dove si torturi è peggio di un carcere speciale, che questo è peggiore di un carcere normale, che tra le carceri normali ci sono vari gradi di sopportabilità, che gli arresti domiciliari o la semilibertà ecc. sono meno peggio del migliore carcere normale, e via dicendo. La considerazione, peraltro assai fondata, che siamo tutti sottoposti al controllo sociale ed espropriati di gran parte di noi stessi o che viviamo in una sorta di megaprigionesociale, con comportamenti e percorsi autorizzati o vietati, non toglie nulla alla materialità dei fatti. Né si può attendere la fatale rivoluzione o la presa di coscienza singola, ma generale, degli individui, né sperare che le istituzioni si spoglino, per merito di consiglieri acuti e umanitari, delle loro funzioni, prima tra tutte quella della regolamentazione sociale e della sanzione. Vanno invece individuate delle forme per battagliare a tutto campo. In una battaglia di tale respiro storico e concettuale, un movimento che si pretenda abolizionista deve saper coniugare le schermaglie giornaliere con l’obiettivo di fondo (vincere la guerra). Se mi batto per la concreta abolizione delle carceri speciali, devo esercitare la massima attenzione affinché questo non si trasformi in una esaltazione delle carceri normali, più «morbide». Se lotto per un’estensione il più possibile progressiva ed egualitaria dei «benefici» (dagli arresti domiciliari alla semilibertà ecc.), non devo mai perdere di vista il mio obiettivo, che è l’abolizione della prigionia e del controllo sociali e della sanzione penale che vi sta a monte. Insomma, dobbiamo reimpadronirci nel sociale e nel culturale di quell’arte della guerra che ha avuto in Sun-Tse e in von Clausewitz i massimi espositori. Sia il «riformismo» che l’«estremismo» non vanno da nessuna parte. L’uno perché diventa ancilla regni o, più volgarmente, ruota di scorta dell’esistente; l’altro perché gode nel condannarsi all’impotenza, dentro uno spirito sacrificale (di sé e di terzi) di cui non è difficile rintracciare la matrice socraticocristiana. (Socrate rifiutò di fuggire dal carcere per non violare delle leggi che peraltro riteneva ingiuste, in quanto assumeva la necessità delle leggi in quanto tali; l’imbonitore di Nazareth pretese che fosse dato a Cesare quel che, apparentemente, era di Cesare e a Dio quel che era, suppostamente, di Dio, scegliendo la testimonianza sulla croce alla ribellione aperta; questi sono due fondamenti della nostra cultura, che vanno radicalmente rimessi in discussione in tutte le loro sfumature, anche quando appaiono lontane dall’origine, ma, in realtà, non hanno rotto l’obbrobrioso cordone ombelicale con loro). Terra terra, là dove siamo e non abbiamo mai smesso di essere, è importante praticare una cultura abolizionista, esprimere ovunque l’importanza della libertà, battersi contro ogni forma di sopraffazione, di negazione, di morte annunciata e differita, nell’universale quanto nel particolare, e viceversa. Io diffido di chi vuole abolire le galere ma, intanto, non fa niente affinché chi ci sta dentro non ne sia strangolato o asfissiato: lì vedo avvoltoi alla ricerca di cadaveri da esibire come ridicoli simboli e poveri stendardi. Il movimento abolizionista (Abolire il carcere) ha da essere capace di pratica quanto di teoria, e all’inverso, dialetticamente. Mai mi si sentirà dire che, in Italia, la legge di riforma detta Gozzini sia giusta e bella, anzi sempre da me si sentiranno delle critiche radicali. Nello stesso tempo faccio quel poco che posso affinché tutti i detenuti ne usufruiscano il più possibile e, se vi sono spazi effettivi, essa venga «migliorata», il che vuol dire s/peggiorata. Mai nessuno mi vedrà in campo a favore delle «riforme», ma sempre mi si vedrà in azione affinché le «riforme» già promulgate vengano estese al massimo. Abolire il carcere è un processo, nel quale l’astuzia, l’intelligenza, il realismo e l’utopismo vanno saviamente combinati, affinché siano un vero cocktail esplosivo. Per concludere non posso che citare Jonathan Swift (I viaggi di Gulliver) verso il quale ho un perenne debito di intelligenza e di piacere. «Sempre era in me il presentimento che un giorno o l’altro avrei recuperato la mia libertà, sebbene mi fosse impossibile immaginare in che modo né far progetti con la minima speranza di successo». (Questo scritto di Riccardo d’Este è stato pubblicato in: Abolire il carcere, ovvero come sprigionarsi, Nautilus, Torino 1990)
Perciò si ha da intervenire concretamente, ciascuno secondo le sue conoscenze e possibilità. In quanto a me, so per esperienza diretta e certa che un carcere dove si torturi è peggio di un carcere speciale, che questo è peggiore di un carcere normale, che tra le carceri normali ci sono vari gradi di sopportabilità, che gli arresti domiciliari o la semilibertà ecc. sono meno peggio del migliore carcere normale, e via dicendo. La considerazione, peraltro assai fondata, che siamo tutti sottoposti al controllo sociale ed espropriati di gran parte di noi stessi o che viviamo in una sorta di megaprigionesociale, con comportamenti e percorsi autorizzati o vietati, non toglie nulla alla materialità dei fatti. Né si può attendere la fatale rivoluzione o la presa di coscienza singola, ma generale, degli individui, né sperare che le istituzioni si spoglino, per merito di consiglieri acuti e umanitari, delle loro funzioni, prima tra tutte quella della regolamentazione sociale e della sanzione. Vanno invece individuate delle forme per battagliare a tutto campo. In una battaglia di tale respiro storico e concettuale, un movimento che si pretenda abolizionista deve saper coniugare le schermaglie giornaliere con l’obiettivo di fondo (vincere la guerra). Se mi batto per la concreta abolizione delle carceri speciali, devo esercitare la massima attenzione affinché questo non si trasformi in una esaltazione delle carceri normali, più «morbide». Se lotto per un’estensione il più possibile progressiva ed egualitaria dei «benefici» (dagli arresti domiciliari alla semilibertà ecc.), non devo mai perdere di vista il mio obiettivo, che è l’abolizione della prigionia e del controllo sociali e della sanzione penale che vi sta a monte. Insomma, dobbiamo reimpadronirci nel sociale e nel culturale di quell’arte della guerra che ha avuto in Sun-Tse e in von Clausewitz i massimi espositori. Sia il «riformismo» che l’«estremismo» non vanno da nessuna parte. L’uno perché diventa ancilla regni o, più volgarmente, ruota di scorta dell’esistente; l’altro perché gode nel condannarsi all’impotenza, dentro uno spirito sacrificale (di sé e di terzi) di cui non è difficile rintracciare la matrice socraticocristiana. (Socrate rifiutò di fuggire dal carcere per non violare delle leggi che peraltro riteneva ingiuste, in quanto assumeva la necessità delle leggi in quanto tali; l’imbonitore di Nazareth pretese che fosse dato a Cesare quel che, apparentemente, era di Cesare e a Dio quel che era, suppostamente, di Dio, scegliendo la testimonianza sulla croce alla ribellione aperta; questi sono due fondamenti della nostra cultura, che vanno radicalmente rimessi in discussione in tutte le loro sfumature, anche quando appaiono lontane dall’origine, ma, in realtà, non hanno rotto l’obbrobrioso cordone ombelicale con loro). Terra terra, là dove siamo e non abbiamo mai smesso di essere, è importante praticare una cultura abolizionista, esprimere ovunque l’importanza della libertà, battersi contro ogni forma di sopraffazione, di negazione, di morte annunciata e differita, nell’universale quanto nel particolare, e viceversa. Io diffido di chi vuole abolire le galere ma, intanto, non fa niente affinché chi ci sta dentro non ne sia strangolato o asfissiato: lì vedo avvoltoi alla ricerca di cadaveri da esibire come ridicoli simboli e poveri stendardi. Il movimento abolizionista (Abolire il carcere) ha da essere capace di pratica quanto di teoria, e all’inverso, dialetticamente. Mai mi si sentirà dire che, in Italia, la legge di riforma detta Gozzini sia giusta e bella, anzi sempre da me si sentiranno delle critiche radicali. Nello stesso tempo faccio quel poco che posso affinché tutti i detenuti ne usufruiscano il più possibile e, se vi sono spazi effettivi, essa venga «migliorata», il che vuol dire s/peggiorata. Mai nessuno mi vedrà in campo a favore delle «riforme», ma sempre mi si vedrà in azione affinché le «riforme» già promulgate vengano estese al massimo. Abolire il carcere è un processo, nel quale l’astuzia, l’intelligenza, il realismo e l’utopismo vanno saviamente combinati, affinché siano un vero cocktail esplosivo. Per concludere non posso che citare Jonathan Swift (I viaggi di Gulliver) verso il quale ho un perenne debito di intelligenza e di piacere. «Sempre era in me il presentimento che un giorno o l’altro avrei recuperato la mia libertà, sebbene mi fosse impossibile immaginare in che modo né far progetti con la minima speranza di successo». (Questo scritto di Riccardo d’Este è stato pubblicato in: Abolire il carcere, ovvero come sprigionarsi, Nautilus, Torino 1990)